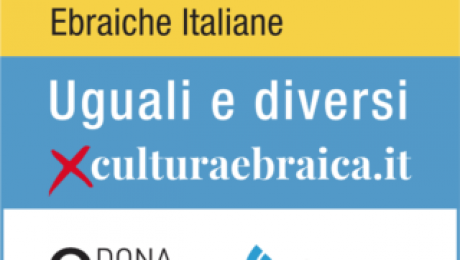Trasmissione della Memoria: un impegno civile
Nell’anno appena trascorso e nei primi mesi di quello corrente, in tutto il Paese, ma in modo speciale a Torino, si sono svolti convegni e seminari, pubblicati libri, realizzati film e documentari, mostre, programmi educativi nelle scuole per ricordare gli ottant’anni dalla promulgazione delle infami leggi razziste.
Macchia indelebile nella storia del nostro Paese, quelle leggi, ideate e scritte di pugno da Mussolini e firmate dal Re Vittorio Emanuele III, che rinnegava in tal modo quei diritti di uguaglianza concessi a tutti i “regnicoli” nel 1848 dal suo antenato Carlo Alberto, “trovarono – come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – a tutti i livelli delle istituzioni, della politica, della cultura e della società italiana connivenze, complicità, turpi convenienze, indifferenza”.
Quella “indifferenza”, che la Senatrice Liliana Segre ha voluto fosse riportata a caratteri cubitali quale monito perenne contro un atteggiamento insidioso e carico di pericoli, ieri come oggi, sul muro del Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, dal quale partivano i convogli per i campi di sterminio, divenuto oggi sede del Memoriale della Shoah.
Per ottant’anni nel nostro Paese il tema delle leggi razziali e della corresponsabilità delle istituzioni e di una parte della società (a parte qualche lodevole e qualificata attività di ricerca e convegnistica, rimasta però confinata all’interno della ristretta cerchia degli studiosi della materia) è stato sostanzialmente rimosso o comunque percepito in versione estremamente edulcorata dall’opinione pubblica, che ha in tal modo evitato di fare i conti con un passato scomodo, come ben più coraggiosamente ha fatto, ad esempio, la Germania.
Soltanto in questi mesi, per la prima volta, abbiamo assistito a un diffuso riconoscimento di quella pagina buia nella storia nazionale, che, con la negazione dei diritti, isolò dal resto della società i cittadini ebrei, aprendo la strada al dramma della deportazione e dello sterminio, ovvero alla negazione delle vite.
In questo 2019 ricorderemo poi, nel centenario della nascita, l’alto insegnamento che ci ha lasciato Primo Levi, di cui abbiamo ascoltato con intensa emozione lo scorso 21 febbraio la lettura di alcune pagine di straordinaria pregnanza e attualità, in una delle baracche del campo di Fossoli, da dove esattamente 75 anni orsono partirono i convogli diretti ad Auschwitz.
“Per noi parlare con i giovani – scriveva Primo Levi nella pagina conclusiva de “I sommersi e i salvati” – è sempre più difficile. Lo percepiamo come un dovere, ed insieme come un rischio: il rischio di apparire anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati: al di sopra delle nostre esperienze individuali, siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato, fondamentale appunto perché inaspettato, non previsto da nessuno. E’ avvenuto contro ogni previsione; è avvenuto in Europa; incredibilmente, è avvenuto che un intero popolo civile, appena uscito dalla fervida fioritura culturale di Weimar, seguisse un istrione la cui figura oggi muove al riso; eppure Adolf Hitler è stato obbedito ed osannato fino alla catastrofe. É avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire”.
Oggi che i testimoni della tragedia delle leggi razziste e della Shoah stanno purtroppo scomparendo uno dopo l’altro, spetta a noi trasmetterne la memoria, non solo negli anniversari o il 27 gennaio, ma 365 giorni l’anno, soprattutto alle giovani generazioni, ignare di quell’orrendo passato o facile preda di una velenosa narrazione distorta, che si sta propagando a macchia d’olio, specie nei social media.
Trasmettere la memoria assume quindi il profondo significato di richiamare tutti a un indifferibile, oggi più che mai necessario, impegno civile e morale contro l’inquietante ripresa e il virulento sviluppo di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo (spesso mascherato da un cosiddetto antisionismo), xenofobia, odio per tutti i diversi, a cui assistiamo sbigottiti in tutto il mondo, in Europa e nel nostro Paese.
Un impegno, come la Comunità Ebraica insieme a quella Valdese ha inteso ribadire nelle manifestazioni delle scorse settimane, in ricordo dell’emancipazione del 1848, e come è apparso nella scritta a caratteri cubitali che ha illuminato la Mole Antonelliana, che ci deve vedere in prima linea “per i diritti di tutti”.
Dario Disegni
- Published in Highlighted Article
Quale Adàr?
Il 5779, come è risaputo, è un anno embolismico che comprende quindi tredici mesi anziché dodici. Alcuni anni, sette in un ciclo di diciannove, hanno questa particolarità dovuta alla necessità che la festa di Pèsach cada in primavera, secondo quanto stabilito dalla Torà (Dt 16,1): “Osserverai il mese della primavera e farai il sacrificio pasquale al Signore tuo D. perché nel mese della primavera il Signore tuo D. ti fece uscire nottetempo dall’Egitto”. Per questo motivo, in determinati anni, viene aggiunto un mese di Adàr; la festa di Purìm viene fissata nel secondo Adàr che, sotto certi aspetti, è quindi considerato quello principale. Il motivo di ciò secondo la ghemarà non è legato però alla maggiore importanza del secondo Adàr rispetto al primo, ma alla volontà di avvicinare il più possibile la salvezza di Purìm a quella di Pèsach. Rimane pertanto la domanda circa quale sia il mese aggiunto, se il primo o il secondo Adàr. Il Talmùd Yerushalmì nel trattato di Meghillà riporta una discussione in merito, ma le Tosafòt (Rosh ha-shanà 19b) giungono alla conclusione che l’Adàr fondamentale sia il secondo, e che il primo sia pertanto quello aggiunto. Altri commentatori, ad esempio Rabbènu Nissìm, sono di un altro parere. Quando ci rapportiamo alla questione può sembrarci di poco conto, per via di un rapporto quantomeno superficiale con il nostro calendario e la nostra scansione del tempo; anticamente il peso di tale problematica doveva essere ben maggiore, con implicazioni in vari ambiti, come quello dei voti e della scrittura dei documenti, con una casistica abbastanza complessa, che non è possibile riportare in questa sede. Ciononostante, anche al giorno d’oggi ci sono delle conseguenze significative, particolarmente in due ambiti, quello dei bar mitzwà e degli anniversari. Per il bar mitzwà: negli anni embolismici, a meno che non si sia nati in un anno embolismico nel primo mese di Adàr, questo viene celebrato nel secondo Adàr (Ramà, Orach Chayìm 55,10). Per gli anniversari invece, c’è una differenza di indirizzo fra i sefarditi e gli ashkenaziti: lo Shulchàn ‘Arùkh infatti stabilisce (Orach Chayìm 568,7) che, se il decesso è avvenuto in un anno con un unico Adàr, si ricordi il defunto (e secondo il loro uso si digiuni) nel secondo Adàr. Il Ramà ritiene invece che si debba digiunare nel primo Adàr. L’uso a Torino, in base alla testimonianza di Isacco Levi z”l, riportatami da Rav Somekh, che ringrazio, è quella, a meno che il decesso non sia avvenuto nel secondo Adàr, di celebrare gli anniversari nel primo Adàr, secondo l’uso ashkenazita. Un’ultima questione riguarda l’insegnamento della ghemarà, secondo cui “da quando entra Adàr si accresce la gioia”. Nei responsa dello Yà’vetz (cap. 89) è spiegato che è evidente che in questo caso ci si riferisca al secondo Adàr, perché il motivo della gioia è, come per la lettura della meghillà fissata nel secondo Adàr, la vicinanza della redenzione di Purìm e di quella di Pèsach. Che D. possa destinare per noi tutti quanto prima una gioia e una redenzione completa.
Rav Ariel Di Porto
Shevat -Adar Rishon 5779 – Febbraio 2019
- Published in Highlighted Article
Alcune questioni sul nostro bet ha-keneset
Una buona parte della vita della nostra comunità si svolge all’interno del Bet ha-keneset. Nel Bet ha-keneset si avvicendano molte persone, frequentatori abituali, altri meno assidui, i ragazzi della scuola, scolaresche in visita. La gestione di tali flussi coinvolge a diverso titolo vari professionali e volontari, che voglio ringraziare per il loro impegno.
Negli ultimi mesi tuttavia è emerso, almeno in tre occasioni, uno spiacevole fenomeno sul quale dovremmo ragionare: il mancato ritrovamento, per non parlare di sparizione, di alcuni oggetti rituali, dal valore economico ed affettivo non indifferente, nella fattispecie, a mia memoria, due paia di tefillin e uno shofar. Le ricerche nei vari ambienti comunitari non hanno portato i risultati sperati, con un danno non indifferente per i proprietari. Le ricerche infruttuose hanno tuttavia evidenziato alcuni punti, che vorrei condividere:
- alcuni cassetti nel Tempio Piccolo, e molti altri nel Tempio Grande, contengono oggetti cultuali e altro materiale appartenente a persone scomparse ormai da tempo. Questi oggetti potrebbero avere un valore affettivo per i loro parenti, e non è logico comunque tenerli in quei cassetti, che potrebbero essere utilizzati da altri;
- altri cassetti contengono con assoluta evidenza libri e altro materiale di proprietà del Bet ha-keneset, negando così di fatto la possibilità di farne uso ai frequentatori. Il numero dei nuovi siddurim, recentemente pubblicati, a disposizione del pubblico negli ultimi mesi ha subito una evidente flessione, e delle due l’una, o sono nei cassetti o sono stati asportati;
- i cassetti non possono essere chiusi a chiave, e risultano accessibili a tutti. Sarebbe opportuno che i proprietari dei vari oggetti li rendessero identificabili, anche per permettere l’identificazione dei libri del bet ha-keneset al fine di metterli nuovamente a disposizione;
- per ultimo, chiederei ai frequentatori di effettuare un controllo sui propri cassetti e segnalare la presenza di libri e quant’altro non di loro proprietà, per avviare le dovute verifiche.
Volevo poi aggiornare i membri della comunità sulla questione-minian, problema che mi sta molto a cuore, e che impegna non poco del mio tempo durante la settimana. Durante l’autunno e l’inverno, tranne rare eccezioni, nelle tefillot infrasettimanali c’è stata una buona continuità nella presenza del minian. Ultimamente tuttavia si è registrata una lieve flessione nelle presenze, che ha penalizzato fortemente il regolare svolgimento delle tefillot. Il nucleo dei partecipanti del lunedì e del giovedì mattina si attesta intorno alle venti persone, e un paio di presenze fisse “nuove” sarebbe in questo frangente determinante, così come la disponibilità a partecipare in modo saltuario (anche una volta al mese) da parte di più persone.
Rav Ariel Di Porto
Adar I-Adar II 5779- Marzo 2019
- Published in Highlighted Article
Anna Vitale, 90 anni di impegno

Novanta anni in sukkà. Un pranzo nel cortile della scuola ebraica di Torino, dove ogni anno è allestita la capanna per la festa di Sukkot. Questa la scelta colta con entusiasmo sia dalla festeggiata, Anna Vitale – figura attiva nel panorama ebraico torinese, emigrata in Argentina da bambina nel febbraio del 1939, poi tornata in età adulta in Italia, che oltre a rivestire la carica di vicepresidente della comunità ebraica di Torino, è stata la prima presidente dell’Archivio Terracini, nato nel 1973, come Associazione, sulla base di un lascito di manoscritti ed edizioni rare del glottologo Benvenuto Terracini – sia da amici e parenti per celebrare in modo non convenzionale una rilevante cifra tonda.
Molti i membri della comunità torinese presenti, tra cui il rabbino Capo rav Ariel Di Porto e il presidente Dario Disegni. A descriverne in maniera scherzosa la personalità, i tratti distintivi, nonché pregi e difetti, i suoi quattro nipoti – Paolo, Alberto, Bruno e Susanna – che a turno, disposti ai quattro angoli della sukkà, hanno letto un componimento a mò di filastrocca.
- Published in Highlighted Article
Un anno per la cultura.
A nome della Comunità ebraica di Torino, ma anche del MEIS e della Fondazione Beni Culturali Ebraici, desidero far giungere a tutti i più calorosi auguri di Shanah Tovah uMetukah.
L’anno 5779, che accogliamo con gioia e colmi di speranze, si apre purtroppo in un quadro denso di gravi preoccupazioni per la virulenta rinascita in Europa e in Italia di fenomeni di intolleranza, di razzismo, di xenofobia, di antisemitismo e di autentico odio nei confronti di Israele, ai quali mai dalla fine della II Guerra Mondiale avevamo assistito in questa dimensione.
Occorre allora un impegno civile consapevole e forte da parte degli ebrei italiani per porre un argine a questa deriva e per porre le basi di un futuro più sereno, nel quale i valori di giustizia, di libertà e di solidarietà ritrovino il loro irrinunciabile posto al centro della vita delle nostre società.
Cultura e formazione, soprattutto dei giovani, dovranno svolgere un ruolo essenziale in questa direzione.
Il lavoro prezioso e incessante svolto dalle Comunità per lo sviluppo della vita ebraica, la diffusione della conoscenza della storia degli Ebrei in Italia, cui si dedica con grande impegno e professionalità il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara, la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ebraico in tutte le Regioni del Paese, promosse con molteplici iniziative dalla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, rappresentano un baluardo importantissimo per contrastare i pericoli che ci circondano e per lavorare tutti insieme, abbandonando contrapposizioni oggi più che mai irresponsabili, per creare le premesse di un anno davvero colmo di benedizioni, che in questi giorni sacri invochiamo da Kadosh Baruch Hu.
Dario Disegni, presidente Comunità ebraica di Torino
(12 settembre 2018)
- Published in Highlighted Article, Community, UCEI
5 per mille – 8 per mille
Ricordate di firmare il 5 per mille a favore della Comunità Ebraica di Torino: C.F. 80082830011
Per destinare l’8 per mille, firmare nel riquadro “Unione delle Comunità Ebraiche Italiane”.
Ogni singola firma è molto preziosa.
- Published in Highlighted Article, — Promemoria di Comunicazioni Varie
CONSAPEVOLEZZA E IMPEGNO
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 chiude con un disavanzo sostanzialmente analogo a quello dell’anno precedente e si attesta intorno a € 741.800, a causa dei notevoli costi connessi alla Scuola e agli altri molteplici servizi erogati dalla Comunità nei diversi settori.
Sul fronte dei ricavi va peraltro rilevato il dato preoccupante della diminuzione del gettito contributivo da parte degli iscritti nonché di quella di donazioni e lasciti, un tempo di una certa importanza, fenomeni che non possono non essere letti come sintomo di una progressiva disaffezione da parte degli Ebrei torinesi nei confronti della loro Comunità.
Una disaffezione che purtroppo si manifesta anche nella scarsa partecipazione, tranne in alcune occasioni particolari, alla vita religiosa, culturale e sociale della Comunità, che il Consiglio promuove con notevoli sforzi organizzativi ed economici, al fine di assicurare sempre servizi di elevata qualità e in grado di incontrare le variegate esigenze degli iscritti.
Viviamo tempi difficili sia a livello internazionale che nel nostro Paese: assistiamo a una crescita di fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, nonché di autentica demonizzazione dello Stato d’Israele, che dovrebbero fare riflettere tutti e indurre a rafforzare il proprio impegno nella e per la Comunità.
Riscontriamo invece una generale apatia che, ad esempio, ha portato nell’ultima Assemblea di bilancio (evento che dovrebbe rappresentare una fondamentale occasione di discutere le linee-guida della programmazione della vita comunitaria e la conduzione della stessa da parte del Consiglio) alla presenza in sala di pochissime persone e che – fatto mai prima d’ora verificatosi – non hanno svolto un solo intervento nel dibattito che avrebbe dovuto seguire la relazione introduttiva.
Nel 2019 l’attuale Consiglio giungerà alla scadenza del proprio mandato quadriennale. Si impone fin d’ora un impegno più consapevole da parte di tutti, in particolare delle fasce dei giovani adulti, che dovranno a breve assumere la responsabilità della conduzione della Comunità con la freschezza delle loro idee e visioni progettuali.
Pur nelle gravi difficoltà in cui ci dibattiamo, cerchiamo tutti insieme di assicurare un futuro degno alla nostra Comunità, per la quale le generazioni che ci hanno preceduto hanno fatto tanti sacrifici.
Lo dobbiamo a loro non meno che ai nostri figli e nipoti e alle generazioni che seguiranno.
DARIO DISEGNI
- Published in Highlighted Article, - Notiziario
70 anni dalla nascita di Israele
- Published in Highlighted Article, - Notiziario
Pian del Lot
- Published in Highlighted Article
La libertà va conquistata (da una derashah di Rav Sacks)
La storia di Pesach è una narrazione molto antica e grandiosa, che narra di come un popolo abbia sperimentato l’oppressione e sia stato condotto alla libertà, dopo un lungo viaggio attraverso il deserto. Questa storia è stata fonte di ispirazione per molti nel mondo occidentale. Durante il Seder di Pesach leggiamo il famoso insegnamento, riportato a nome di R. Gamliel, secondo il quale chi non parlava del qorban Pesach, della matzah e del Maror non aveva adempiuto al proprio obbligo. Il motivo per cui sono stati decisi questi elementi è evidente: il sacrificio pasquale rappresenta la libertà, le erbe amare, per via del loro sapore, rappresentano la schiavitù. Il pane azzimo combina i significati. Era il pane che i nostri padri mangiavano in Egitto, quando erano schiavi, è il pane che mangiarono quando uscirono dall’Egitto da uomini liberi. Non solo il simbolismo, ma anche l’ordine in cui gli elementi compaiono è interessante. E’ strano che i simboli della libertà precedano quelli della schiavitù. Ci saremmo di certo aspettati il contrario. La risposta che viene data è che la schiavitù è veramente amara solo per chi conosce la libertà. Chi dimentica la libertà, prima o poi si abituerà alla schiavitù. Non c’è peggior esilio della dimenticanza di essere in esilio. Per comprendere la libertà, dobbiamo capire anzitutto che significa non essere liberi. La stessa libertà, come è noto, ha varie dimensioni, che sono riflesse in ebraico da due diversi termini, chofesh e cherut, “libertà da” e “libertà di”. La prima è la libertà che uno schiavo acquisisce quando viene liberato. Non si è più soggetti alla volontà di qualcun altro. Ma questa libertà non è sufficiente per costruire una società libera. Un mondo in cui ciascuno può fare quello che vuole sfocia facilmente nell’anarchia e poi nella tirannide. Questa liberazione è solo l’inizio della libertà, non la sua destinazione finale. Il secondo tipo di libertà è la libertà collettiva, in cui la mia libertà rispetta la tua. Una società libera è una conquista di carattere morale, alla quale la Torah tende. Esercizio della giustizia e della compassione, nel riconoscimento della sovranità di D. e dell’integrità del creato. Il messaggio di Pesach è potente ancora oggi: il predominio del diritto sul potere; l’idea che la giustizia appartiene a tutti, non a qualcuno; l’uguaglianza di tutti gli esseri umani sotto D. Ci vollero molti secoli perché questa visione venisse condivisa dalle democrazie occidentali, e, nostro malgrado, non ci sono garanzie che rimarrà così. La libertà è una conquista morale, e se non c’è uno sforzo educativo continuo, si atrofizza. Questi messaggi, che risalgono ad alcune migliaia di anni fa, sono oggi più che mai attuali.
Pesach kasher wesameach a voi e ai vostri cari.
Rav Ariel Di Porto
aprile 2018 – nissan-yiar 5778
- Published in Highlighted Article, - Notiziario


 Italiano
Italiano